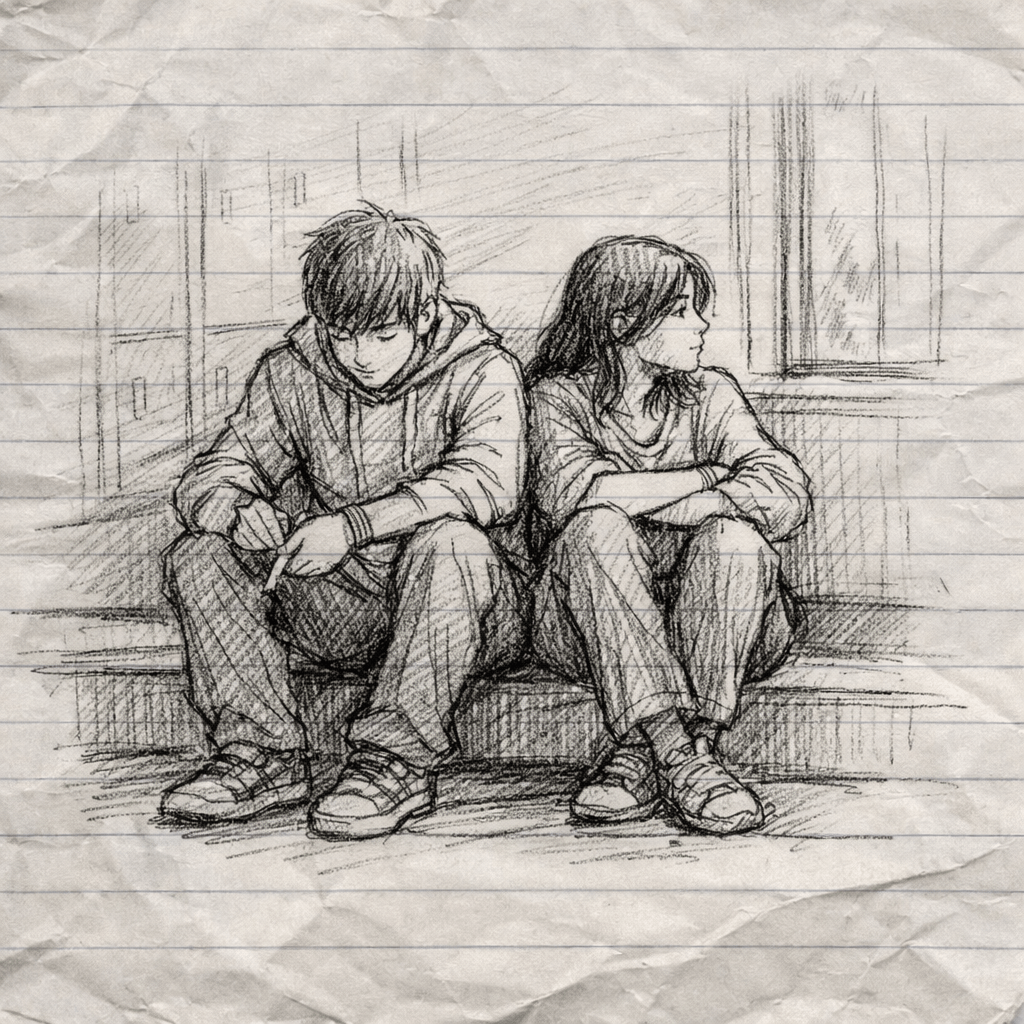Nessuno mi aveva detto che per innamorarmi avrei dovuto firmare dei moduli.
Cioè, io lo sapevo che nella vita adulta esistono i moduli. Sono ovunque. Modulo per la mensa, modulo per l’uscita anticipata, modulo per respirare in modo corretto. L’ultimo forse l’ho sognato, ma non ci giurerei.
Però non immaginavo che l’amore, a quindici anni, avesse già un’area amministrativa.
E invece sì.
La prima volta che mi sono innamorato è stato un martedì.
Me lo ricordo perché il martedì ho laboratorio di competenze sociali, che è un nome elegante per dire che ci mettono in cerchio e ci fanno parlare di cose che non diremmo neanche sotto tortura. Tipo “qual è la tua emozione dominante oggi?”, oppure, “da uno a dieci, quanto ti senti compreso?”.
Io, di solito, rispondo sei. Non perché mi senta sei. Ma perché sei è un numero gentile. Non insulta nessuno. Non mette in crisi la psicologa. È un numero che si siede composto e aspetta che passi la tempesta.
Quella volta ero entrato in aula con l’intenzione di essere un sei come sempre.
Poi l’ho vista.
Non l’avevo mai guardata davvero. Lei era sempre stata lì, come una sedia che non noti finché qualcuno non la sposta.
Sta seduta vicino alla finestra, ha i capelli che sembrano sempre sul punto di scappare via, e tiene la penna con una precisione che fa pensare che, se un giorno dovesse firmare la pace nel mondo, non sbaglierebbe una virgola.
Si chiama Bianca. Sì, proprio Bianca. Lo so, sembra un nome inventato apposta per essere una metafora, ma la vita a volte ha poca fantasia e si ripete.
Io mi ero seduto due file dietro. Avevo già pronto il mio “sei” e la mia faccia neutra.
Poi lei si è girata, mi ha guardato, e ha detto: «Hai la felpa al contrario.»
Io ho abbassato lo sguardo. Aveva ragione. La zip dietro. Il cappuccio davanti. Praticamente ero un umano in fase di montaggio.
«Lo so», ho risposto.
Non era vero. Ma era la risposta migliore. Perché se avessi detto no, lei avrebbe avuto pietà. E io la pietà la prendo male, come il lattosio.
Bianca non ha avuto pietà. Ha annuito come se fosse normale andare in giro vestiti così e ha aggiunto: «Ti sta bene.»
Ecco. In quel momento io mi sono innamorato.
Non perché mi avesse fatto un complimento. I complimenti mi mettono a disagio.
È che lei non aveva fatto la faccia da adulto. Quella faccia da “poverino”, da “bravo che ci provi”, da “ti vedo con la lente d’ingrandimento e adesso ti aggiusto”.
Aveva detto ti sta bene come si dice oggi piove, senza drammi, senza obiettivi, senza schede.
Poi è iniziato il laboratorio. La psicologa ci ha fatto la domanda di rito: «Che cos’è per voi una relazione sana?»
Io ero pronto a dire qualcosa tipo: «Una relazione sana è quando non ti senti giudicato», che è una frase valida, ma suona anche come un poster motivazionale.
Bianca invece ha alzato la mano e ha detto: «Una relazione sana è quando puoi stare zitto e l’altro non va in panico.»
Silenzio. La psicologa ha sorriso con quella soddisfazione da “ecco, questo lo scrivo nel verbale”.
Io, però, non ho pensato al verbale. Ho pensato: lei lo sa.
Lei sa com’è essere guardati come un problema da risolvere. Sa com’è parlare e vedere le persone scambiarsi occhiate, come se tu fossi un documentario. Sa anche com’è stare zitto e sentire gli altri riempire il silenzio al posto tuo.
Finita la lezione, siamo usciti in corridoio. Io stavo facendo la mia solita traiettoria: muro–armadietto–uscita, senza fermate.
Bianca mi ha raggiunto e ha detto: «Hai fame?»
Era una domanda semplice. Eppure, rara. Perché nessuno mi chiede mai “hai fame?” senza sottotesto.
«Sì», ho detto.
«Allora vieni.»
Non “ti accompagno”. Non “ti aiuto”. Solo vieni. Come se fosse normale che io venissi.
Siamo andati al bar davanti alla scuola, quello dove fanno i tramezzini tristi e i cornetti che sanno di ieri, ma costa poco e ci lasciano stare.
Abbiamo mangiato in silenzio. Che, per me, era già un appuntamento romantico. A un certo punto Bianca ha tolto il telefono dal tavolo e l’ha messo nello zaino.
«Così non mi viene da controllare» ha detto.
«Cosa?»
«Se sto facendo bene. Se sto facendo la cosa giusta.»
Io vivo con l’idea di essere osservato. Non in modo paranoico. In modo statistico. Tipo grafico a torta: “oggi ha mantenuto un atteggiamento collaborativo”. “Oggi ha sostenuto un contatto oculare di tre secondi”. Tre secondi. ome se la vita fosse una gara di apnea.
Bianca ha preso un tovagliolo e ci ha disegnato sopra una specie di mappa. Un rettangolo, due cerchi, delle frecce.
«Questa è la scuola» ha detto. «Questo è il corridoio. Queste sono le persone che ti dicono cosa fare. E questo», ha indicato uno spazio bianco, «è l’unico posto dove nessuno decide.»
«Che posto è?»
«Non lo so ancora. Però ci voglio stare.»
Io ho guardato quel vuoto e ho pensato che, se esistesse un posto così, io ci avrei messo una tenda e un cartello: qui non si compila.
Da quel giorno abbiamo iniziato a stare insieme. Non in modo ufficiale. Non con foto. Non con “noi”. Stare insieme come due persone che si incontrano spesso e, senza che nessuno lo dichiari, smettono di essere sole.
E ovviamente è diventato un problema.
All’inizio è stato un problema piccolo. Tipo: “Bianca si distrae”, “tu ti agiti”, “state sempre vicini”. Poi il problema ha iniziato a crescere.
Un giovedì ci hanno chiamati. Non convocati. Chiamati. Ma se ti chiamano in una stanza con tre adulti e una cartellina, non è mai per offrirti una caramella.
C’erano l’insegnante di sostegno, la psicologa e una persona che non conoscevo, ma aveva la stessa faccia di chi ha letto tutti i manuali del mondo.
La psicologa ha iniziato con la voce morbida: «Allora… abbiamo notato una bella vicinanza tra voi.»
«È importante che le relazioni siano vissute in modo adeguato» ha aggiunto l’insegnante.
Adeguato. Un’altra parola che mi fa prudere la pelle. Adeguato a cosa? A chi?
La persona nuova ha aperto la cartellina. «Vorremmo costruire con voi un percorso di consapevolezza affettiva.»
Bianca ha alzato lo sguardo. «E se invece non costruissimo niente?»
«È per la vostra tutela» ha detto la persona con la cartellina.
«La tutela la sento sempre addosso» ho detto. «Mi pesa.»
Si sono voltati verso di me come se avessi appena parlato in una lingua estinta.
«Dobbiamo evitare dipendenze affettive» ha detto qualcuno.
Io ho pensato: scusate, ma io non sono un vizio.
Bianca ha fatto un respiro. «Ci piace stare insieme.»
«Ed è bellissimo» ha risposto l’adulto. «Ma ci sono delle regole.»
E lì ho capito tutto. Non ce l’avevano con l’amore. Ce l’avevano con la libertà. Non sapevano dove metterla. Non c’era una tabella per misurarla.
Da quel giorno ci hanno separati di banco. Non troppo. Quel tanto che basta per dire “non stiamo vietando”. Ci hanno anche dato dei compiti. Compiti veri. Tipo: “Esprimere un bisogno”. “Stabilire confini”.
Io non dico che siano cose inutili. Dico solo che è strano ricevere una scheda per amare.
Una sera Bianca mi ha scritto: Domani, nell’intervallo, vieni dietro la palestra.
Dietro la palestra c’è un angolo dove nessuno va. Puzza di piscio e di pioggia. Ci sono due gradini e un muro con scritte vecchie. Ci siamo seduti lì.
Bianca ha tirato fuori dallo zaino un foglio.
«Che cos’è?»
«Il mio piano.»
«Piano di vita?»
«No. Piano di fuga.»
Sul foglio c’erano due colonne: “cose che voglio” e “cose che gli altri vogliono per me”. Mi ha passato la penna.
Ho scritto: Sedermi vicino a te senza che qualcuno lo chiami dipendenza.
Lei ha scritto: Che tu non ti senta un caso quando mi guardi.
Non ho risposto. Ho piegato il foglio in quattro e l’ho messo in tasca.
«Lo salvo» ho detto. «Così non possono archiviarlo.»
Nei giorni dopo non è successo niente di clamoroso. Nessuna fuga. Nessuna dichiarazione. Solo una cosa. Ogni volta che ci separavano, noi trovavamo un modo per tornare vicini. Una penna passata. Un foglio scambiato. Una battuta detta piano.
Ho capito che l’amore, forse, è questo. Non un gesto enorme, ma una somma di piccole disobbedienze gentili.
Un pomeriggio, mentre uscivamo, la psicologa mi ha fermato. «Come va con Bianca?» ha chiesto, con la voce da uno a dieci.
Io ho pensato al foglio in tasca.
«Va come va una cosa che non state gestendo voi.»
«È un bene?»
«Sì», ho detto. «È un bene.»
Poi sono uscito. Bianca mi aspettava fuori dal cancello, con i capelli pronti a scappare e il sole negli occhi. Mi ha guardato e ha detto: «Hai la giacca chiusa male.»
Io ho abbassato lo sguardo. Aveva ragione.
«Lo so.»
«Ti sta bene» ha detto lei.
E io ho pensato che forse l’amore non è fare quello che vuoi.
È voler restare, anche quando ti dicono che sarebbe meglio di no.